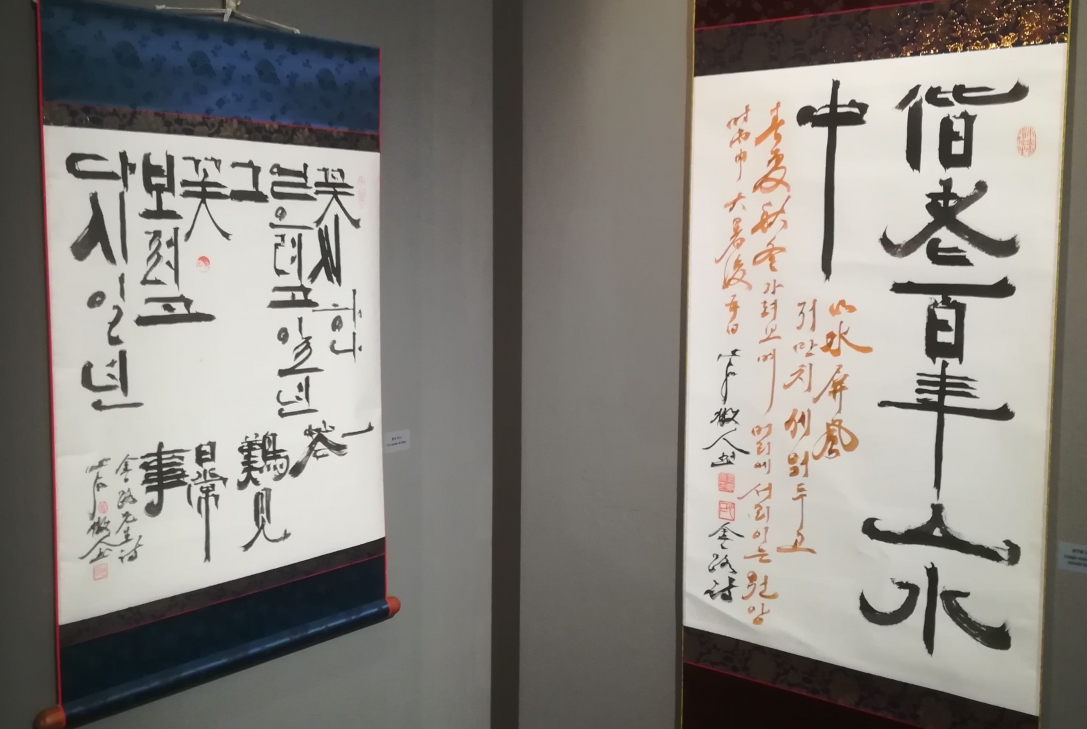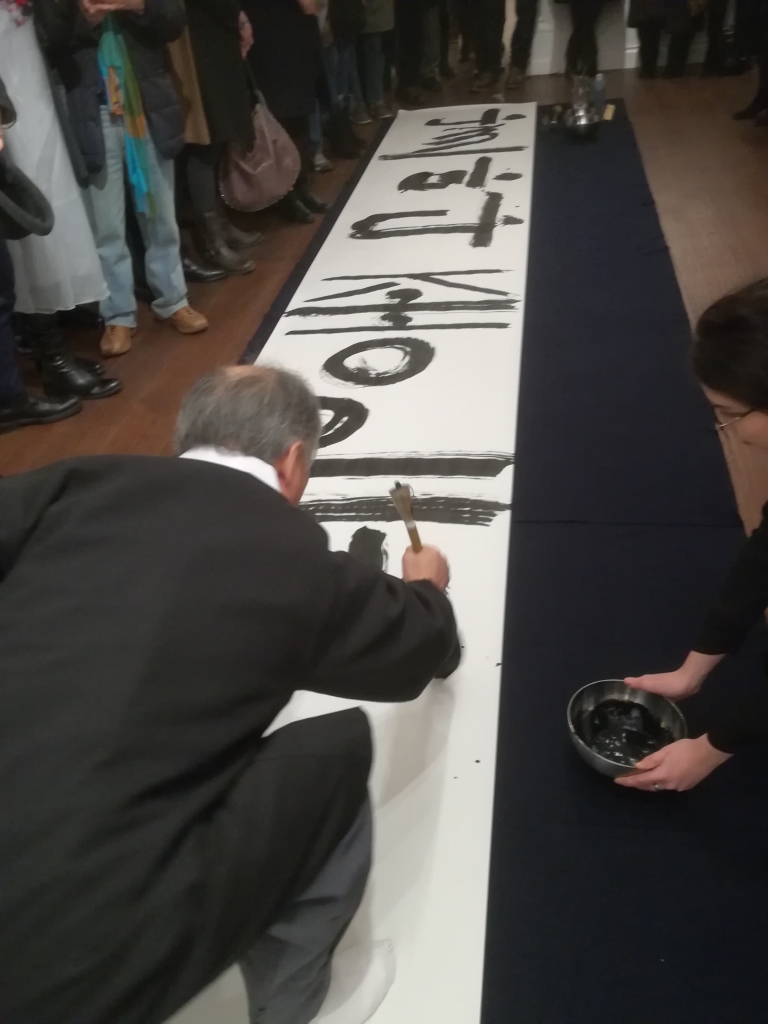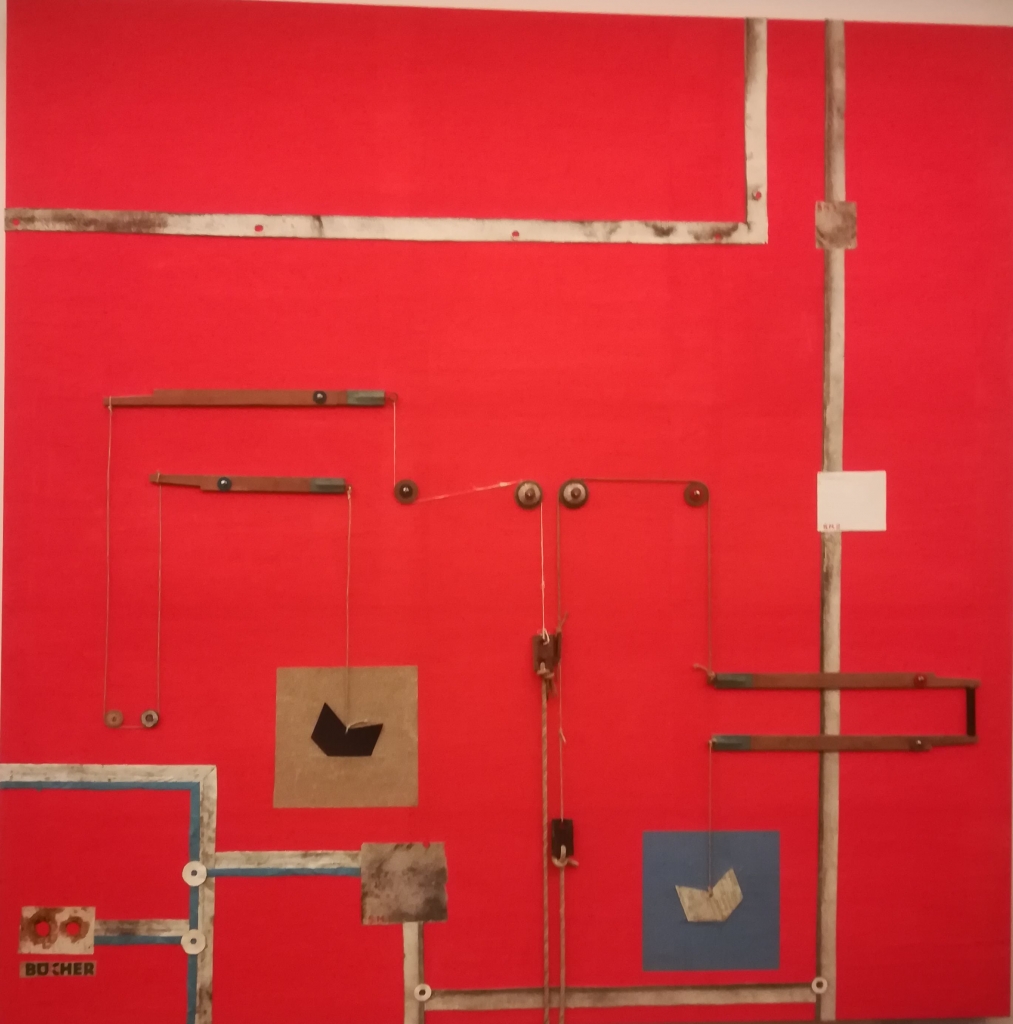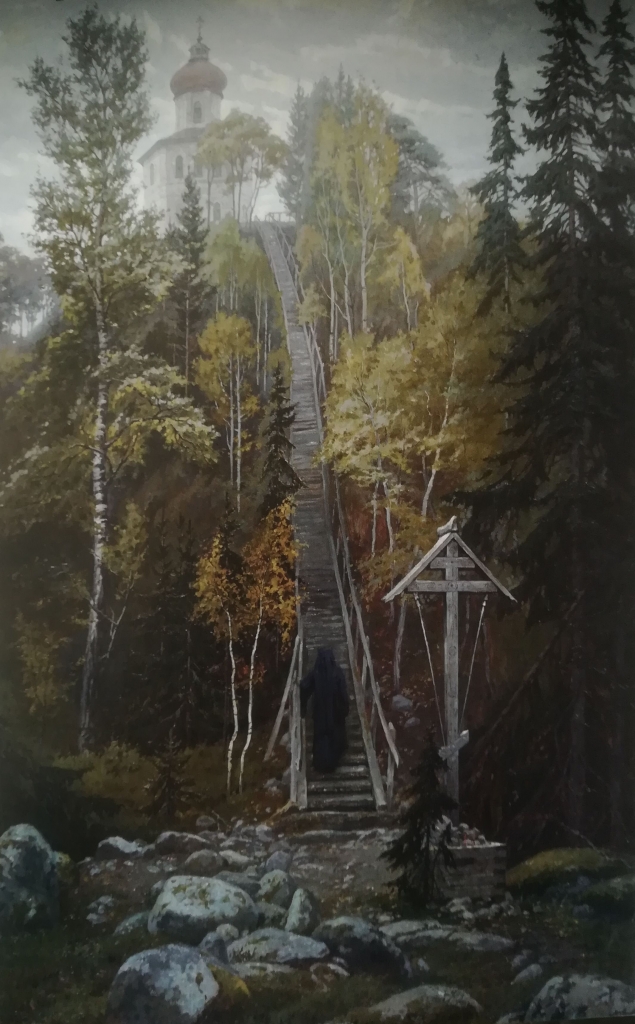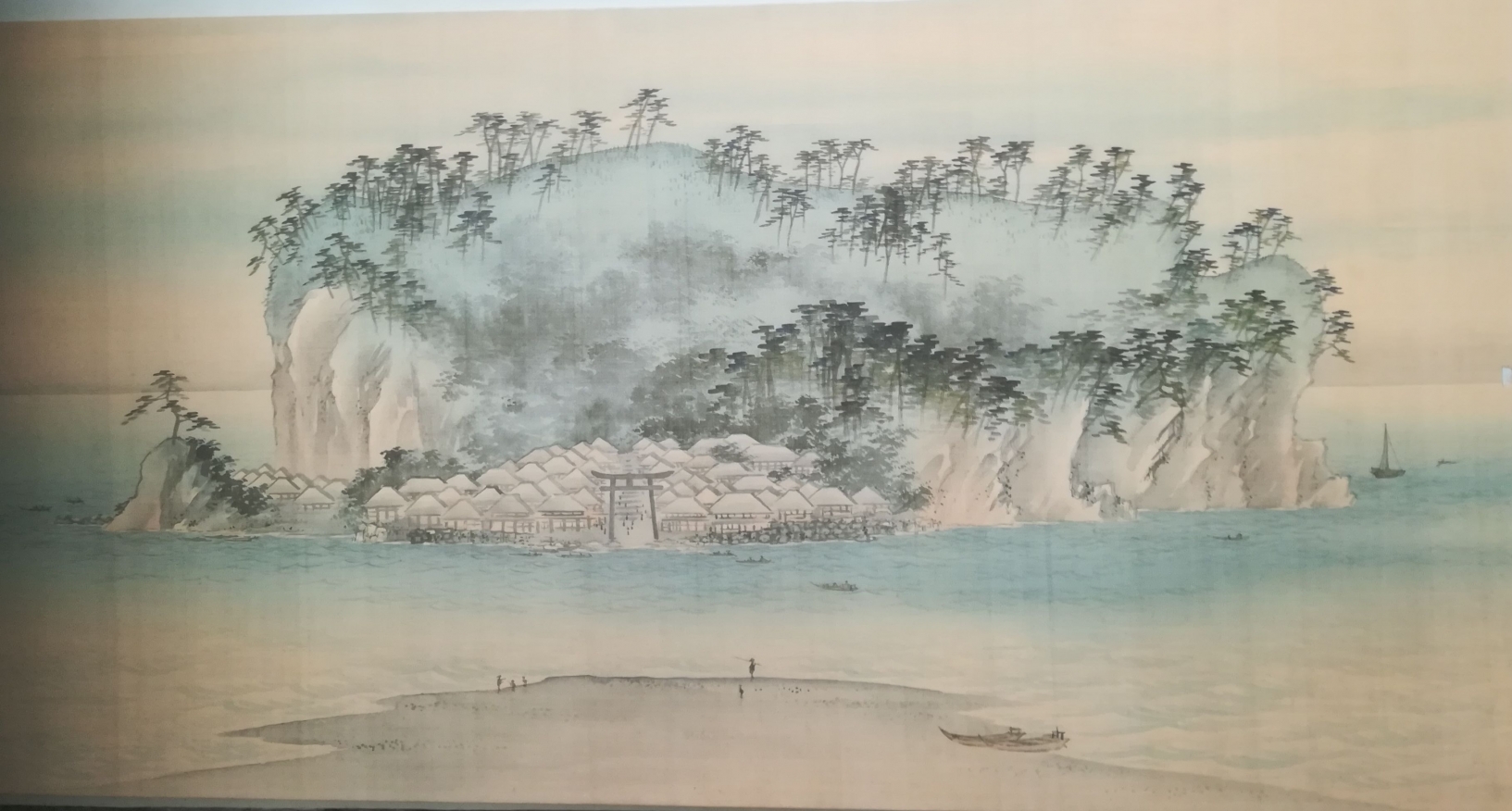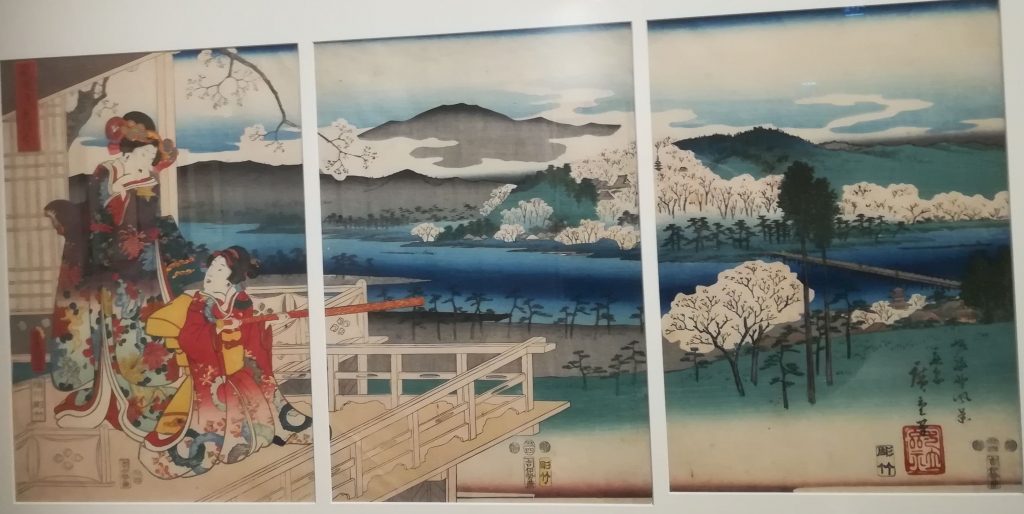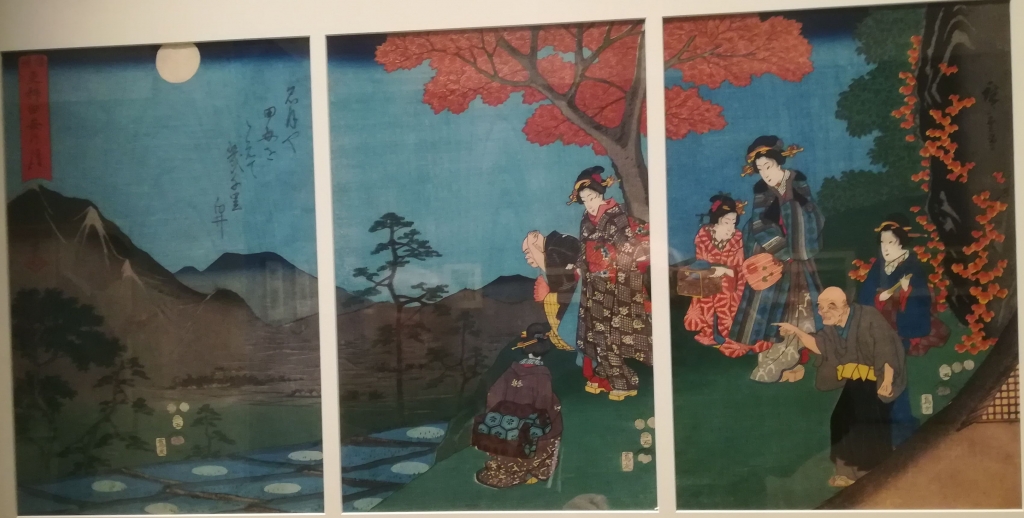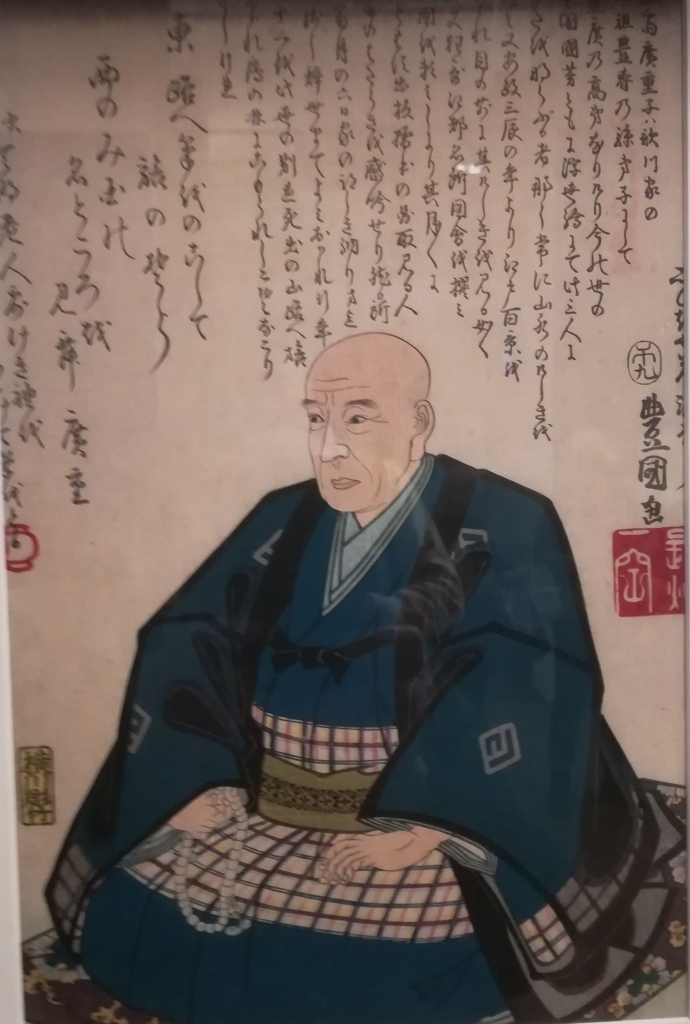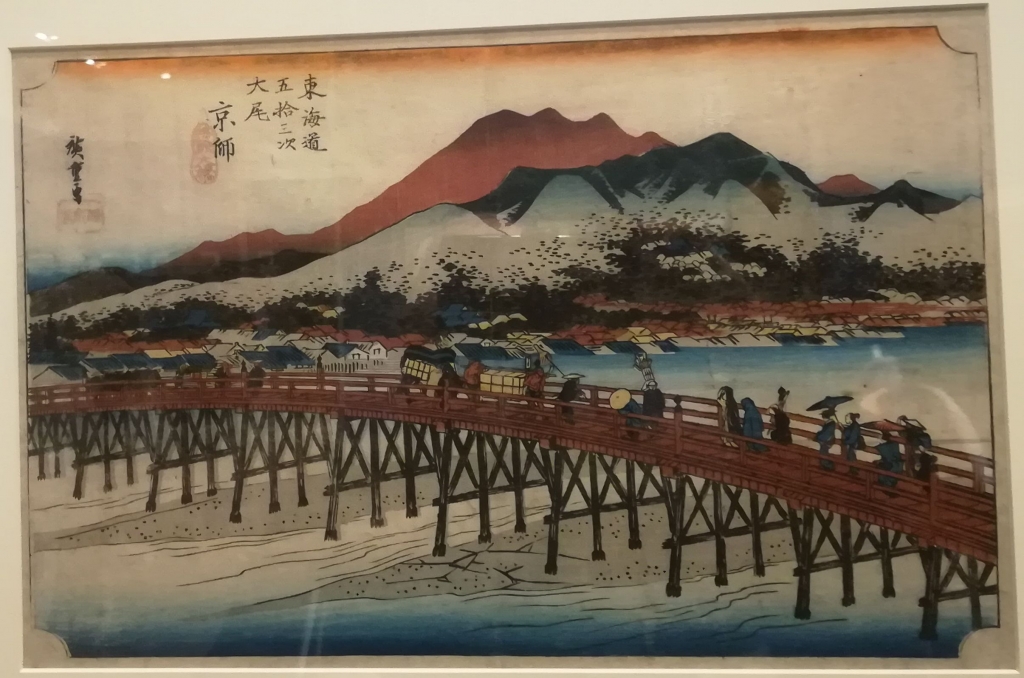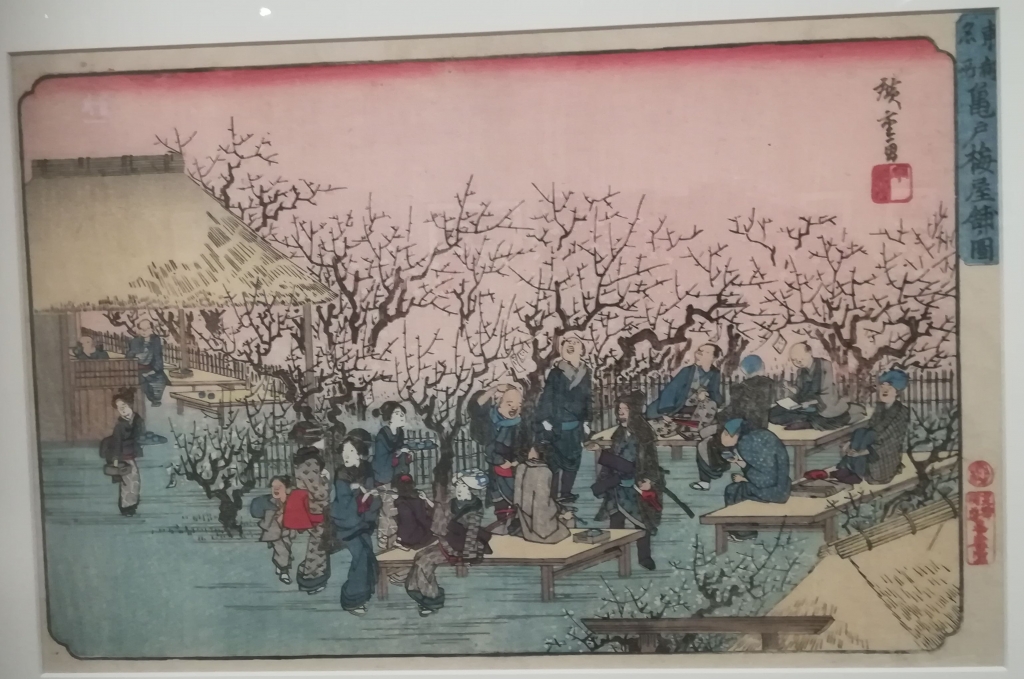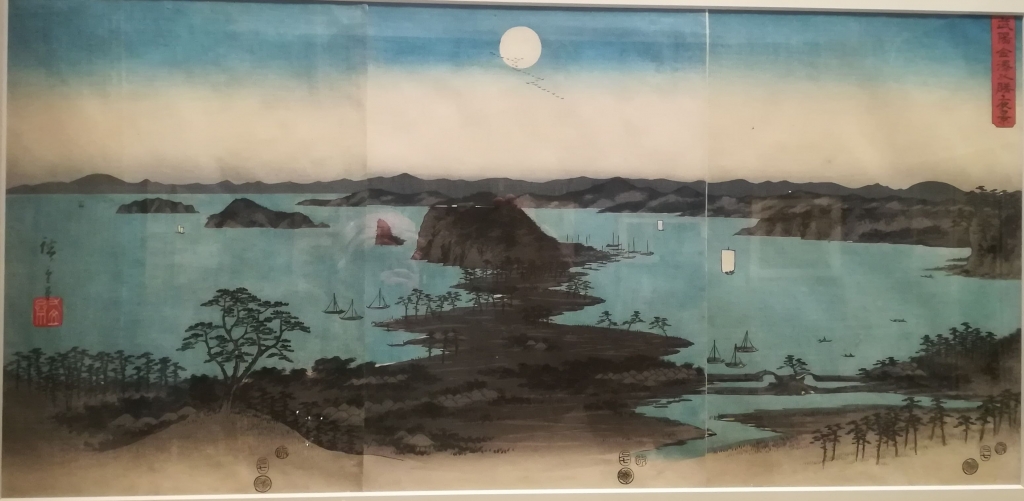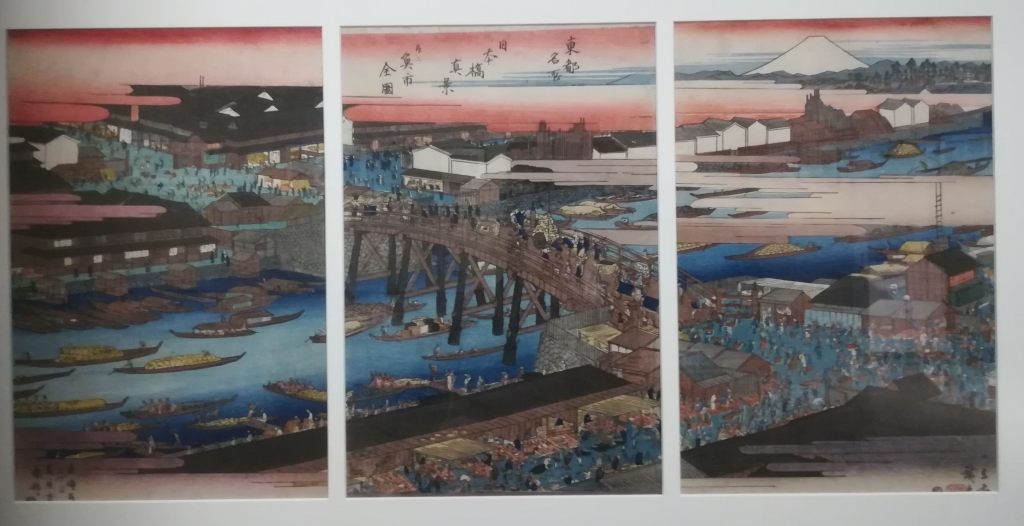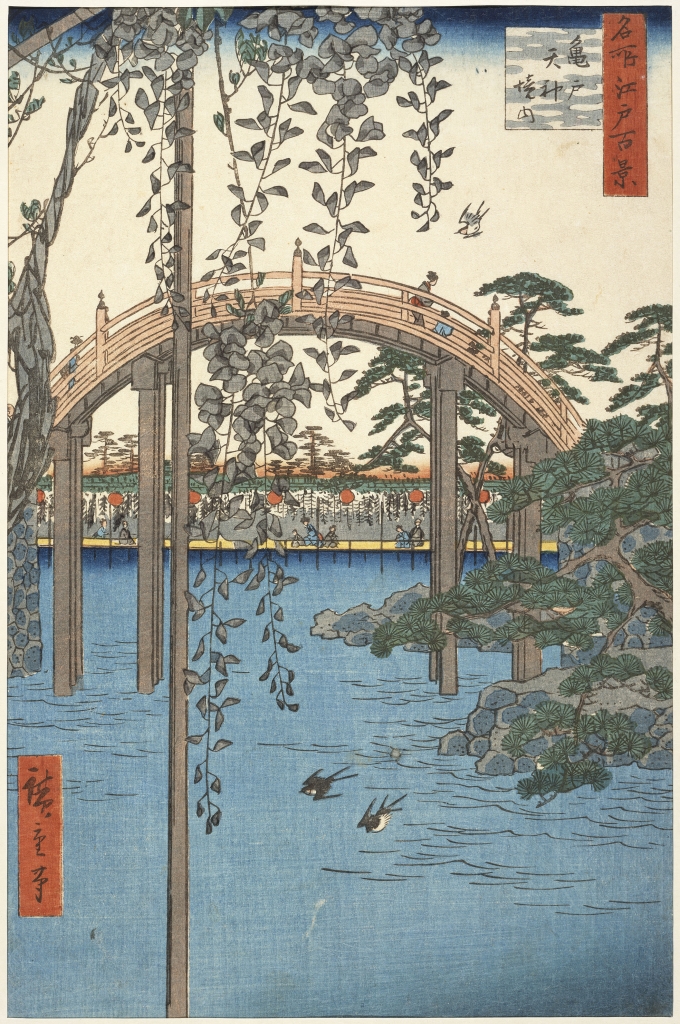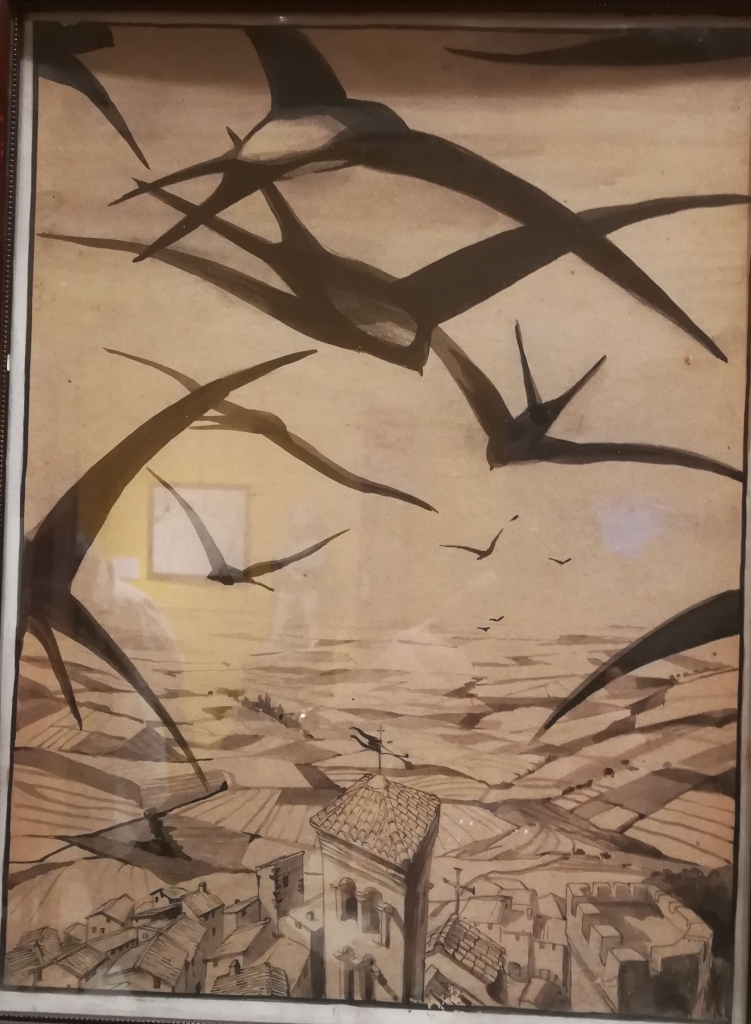Spello – Villa dei mosaici.- Una buona occasione in più per scoprire una meta turistica di grande interesse ed un affascinante sito archeologico.
Testo e Foto di Mariagrazia Fiorentino e Donatello Urbani
Soggetti e temi presenti nei pavimenti musivi di questa villa suburbana di un aristocratico romano, recentemente riportati alla luce ed alla pubblica fruibilità, sono quell rimasti validi ed attuali tutt’oggi malgrado siano trascorsi ben milleottocento anni. Spello è una meta turistica che fa della vita tranquilla in una natura amena, un’ottima cucina accompagnata da un eccellente vino la propria caratteristica. Per la verità in questo frattempo un motivo in più si è aggiunto: quello culturale. Spello offre oggi alle consolidate opportunità di un’eccellente ospitalità, percorsi culturali di notevole interesse: una per tutte Le Torri di Properzio, oppure la Cappella Baglioni affrescata da Pinturicchio, anche senza prendere in considerazione la Pinacoteca Civica che da sola merita la visita a questa affascinante cittadina.
Dalle parole della dott.ssa Marica Mercalli, Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell’Umbria, scopriamo la vera “star” di questi percorsi incentrati su un: “eccezionale tesoro archeologico nel cuore dell’Umbria che con i suoi quasi 500 metri quadrati recuperati in questa Villa dei Mosaici di Spello è una delle scoperte archeologiche più straordinarie dell’Umbria. Dieci ambienti dai pavimenti a mosaico di grande bellezza, con straordinarie decorazioni policrome: elementi geometrici, figure umane, animali selvatici e fantastici. I mosaici che più degli altri meritano una menzione sono:
Stanza degli uccelli: Presenta una decorazione geometrica con sei ottagoni che racchiudono uccelli, tra cui le pernici. Richiamano la caccia e la buona tavola.
Stanza delle anfore: Particolarissima decorazione con quattro anfore stilizzate disposte a croce, un soggetto che trova confronto solo con un pavimento proveniente da una villa di Roma, nell’area di Tor Marancia. La decorazione doveva riferirsi alla produzione di vino, attività del padrone della Villa. Forse si trattava di un ambiente per i pasti privati.
Il triclinio: È l’ambiente principale della Villa, la stanza da pranzo usata per banchetti dove si mangiava sdraiati come nell’antica Grecia. La decorazione dei pavimenti è incentrata su Bacco, la vendemmia e il vino. Presenta una decorazione denominata “a cuscini”. All’interno ci sono animali selvatici e domestici (pantera, cervo, cinghiale, anatra, etc.), figure fantastiche (tigri marine) e figure umane.
Di grande valore è la scena centrale di mescita del vino. Un servitore sorregge sulle spalle un’anfora dalla quale versa il vino in una coppa, tenuta in mano da un coppiere. Il vino traboccante è raccolto in un cratere (recipiente dell’epoca) poggiato a terra. Altri personaggi sono disposti simmetricamente con in mano elementi vegetali o attributi legati al mondo dell’agricoltura (come falce e spighe di grano). I ritmi della vita e della natura sono scanditi nei mosaici della Villa probabilmente da questi personaggi raffiguranti le quattro stagioni.
Stanza del sole radiante: Deve il nome all’ottagono centrale con un sole radiante che irraggia una vegetazione palustre, costituita da canne con infiorescenze. Alcuni uccelli sono disposti tra la vegetazione: si riconoscono un’upupa e un’anatra. Il sole, l’ambiente palustre e l’abbondanza di uccelli richiamano la fertilità del territorio.
Stanza del mosaico geometrico: È’ probabile che si trattasse di una camera di letto. La stanza ha una pavimentazione a mosaico con motivo detto a ‘croce di quattro squadre’, una decorazione semplice ed elegante, giocata sul contrasto cromatico, che dà vita ad altre geometrie. Importanti sono i resti delle pitture murali, con campiture in rosso, giallo e blu, su cui erano dipinti motivi sia floreali sia legati al mondo mitologico marino.
Stanza degli scudi: Questa stanza presenta un motivo geometrico a “pelte” continue, ossia lo scudo greco a forma di luna crescente. All’interno, entro due cornici lineari rosso-nere, sono disposti in fila rombi a lati curvilinei.
Ambiente riscaldato: Appartiene all’epoca più antica della Villa. La presenza di “suspensurae”, i pilastrini in mattoni che permettevano di creare un’intercapedine tra le fondamenta dell’edificio e il pavimento, ci testimonia che si trattava di una stanza riscaldata.
Il peristilio: È il cosiddetto portico che cingeva il giardino o cortile interno al centro della Villa. Presenta una pavimentazione geometrica a tessere monocrome. Non sono state trovate tracce evidenti del colonnato, ma si può ipotizzare che ci fosse, come era prassi per questo ambiente. Il peristilio non era soltanto un’elegante comodità, ma rimandava al prestigio della cultura greca.
L’intero complesso che è stato ribattezzato dagli archeologici La Villa dei Mosaici di Spello si trovava lungo un ramo secondario della Via Flaminia, che da Roma arrivava a Rimini attraversando l’Umbria. I venti ambienti riportati alla luce sono pertinenti al settore centrale della villa, per una superficie totale di circa 500 metri quadrati. Gli studi hanno individuato due fasi costruttive ben distinte: la prima di età augustea (27 a.C.-14 d.C.), attestata dai resti di pavimentazione in cementizio, la successiva in piena età imperiale, tra il II e gli inizi del III secolo d.C. La fluidità del disegno e la resa cromatica, soprattutto del triclinio, testimoniano l’alta qualità tecnica della bottega, le cui maestranze potrebbero venire da Roma per rispondere all’esigenza di un committente particolarmente facoltoso e di una specifica collocazione sociale. L’identità del proprietario è ignota, non ci sono iscrizioni con il suo nome, né finora altri indizi della sua presenza a Spello. Sicuramente doveva trattarsi di una persona ricca e potente, viste le dimensioni della dimora, proprio a ridosso delle mura di Spello. Lo studio del mosaico al centro della stanza principale, con scena di mescita del vino, ha fatto ipotizzare verosimilmente che si trattasse di un viticoltore. Il progetto architettonico di questa villa restituisce una struttura contemporanea, in dialogo armonico con la storia e il paesaggio. Nella musealizzazione sono stati realizzati percorsi per la visita alle stanze della villa e spazi destinati a sala multimediale e didattica. L’attualità del progetto inteso a rendere fruibile e vivibile con le realtà del luogo di questo importante sito archeologica troverebbe nel riproporre ricette culinarie della Roma imperiale un valido supporto. Un buon punto di partenza è offerto dall’Università di Perugia che attraverso una associazione culturale dal suggestivo titolo “Archeofood” ha riproposto alla moderna enogastronomia antiche pietanze e bevande fra le quali spicca per i buoni risultati commerciali ottenuti una salsiccia a base di farro, mandorle e carne suina insieme a delle mostarde a base di mosti cotti di vini umbri. I proventi di questa attività saranno devoluti a sostegno delle attività archeologiche della Regione Umbra.
Villa dei Mosaici di Spello – Visitabile con un calendario articolato lungo tutto l’arco dell’anno. Consigliabile consultare il sito www.villadeimosaicidispello.it È sempre garantita l’apertura straordinaria su prenotazione. La visita può essere assistita da una app, moderna e multimediale, che permette di esplorare tutto il fascino dell’antica villa romana di 2000 anni fa con ricostruzioni in 3D, e da un’audioguida. Costi dei biglietti d’ingresso; Intero € 6; ridotto A € 4 (gruppi superiori alle 15 unità, convenzionati); ridotto B € 2 (ragazzi tra 6 e 14 anni); speciale residenti € 2; omaggio (bambini fino 6 anni, fruitori delle attività didattiche, giornalisti con tesserino, soci ICOM). Nei giorni di apertura del sito delle Torri di Properzio il biglietto ne comprende la possibilità di visita senza costi aggiuntivi. È possibile prevedere l’emissione di un biglietto unico con la Pinacoteca Comunale (biglietto unico della convenzione Umbria Terre Musei che permette l’accesso a 16 musei della regione: www.umbriaterremusei.it). Intero € 11; ridotto A € 8 (gruppi superiori alle 15 unità, convenzionati); ridotto B € 3 (ragazzi tra 6 e 14 anni); omaggio (bambini fino 6 anni, fruitori delle attività didattiche, giornalisti con tesserino, soci ICOM). Costo delle visite guidate in italiano € 80; visita guidata in lingua € 100. Prevista un’attività didattica. Per informazioni/prenotazioni: numero verde 800 96 1993 oppure telefono +39 0742 302239 – info@villadeimosaicidispello.it. Per chiamate da reti cellulari 0744. 422848 (lunedì-venerdì 9-17, sabato 9-13, escluso festivi) – callcenter@sistemamuseo.it